Il Dantedì rappresenta un’opportunità privilegiata per approfondire la figura di Dante Alighieri.
Una giornata di eventi culturali, gastronomici, storici.
Il Dantedì è un’occasione per studiare, approfondire e conoscere la figura di Dante Alighieri non esclusivamente come sommo poeta, ma come acuto osservatore della società e della quotidianità medievale. La sua Commedia, pur essendo un’opera teologica e filosofica, si rivela anche un potente documento culturale, capace di restituire con vivacità i costumi, i valori e i consumi alimentari del suo tempo. Il cibo, la fame, la convivialità e la loro antitesi morale (come la gola o la carestia) assumono nel poema una funzione narrativa e allegorica che consente riflessioni di ampio respiro antropologico e storico.
Il Dantedì offre lo spunto per celebrarne la memoria del sommo poeta anche attraverso un’esperienza enogastronomica: significa pertanto riconoscere la stratificazione semantica della sua opera, in cui la tavola diviene uno specchio dell’anima e dei suoi viaggi. Un menu ispirato alla Divina Commedia non è solo una curiosità tematica, ma un esercizio culturale: un modo per trasformare la lettura in esperienza sensoriale e storica.
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”… con la consapevolezza rinnovata che anche il gusto può essere veicolo di conoscenza.
Il 25 marzo non è una data scelta a caso.
Il Dantedì, istituito nel 2020 dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero della Cultura, celebra Dante Alighieri, padre della lingua italiana, proprio in questo giorno perché secondo molti studiosi sarebbe l’inizio simbolico del viaggio ultraterreno narrato nella Divina Commedia.
Non il giorno della sua nascita (maggio o giugno 1265), né della morte (14 settembre 1321), ma quello dell’inizio di tutto: “Nel mezzo del cammin di nostra vita”.
La giornata è dedicata a letture pubbliche, eventi teatrali, conferenze, iniziative scolastiche e – sempre più spesso – percorsi enogastronomici che ripercorrono l’Italia dantesca tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, riscoprendo piatti, ingredienti e vini menzionati o evocati nell’opera.
La Commedia a tavola: cibo e vino nell’opera di Dante
Anche se non si tratta di un’opera culinaria, la Divina Commedia è disseminata di riferimenti al cibo, al vino, alla fame e alla sete, usati sia come simboli morali sia come strumenti realistici per evocare emozioni. Il linguaggio di Dante, fortemente visivo e sensoriale, si presta naturalmente a evocare sapori, profumi, e immagini legate alla tavola.
I piaceri del corpo, i peccati della gola e i cibi dell’epoca si intrecciano al viaggio dell’anima, offrendo una lettura sorprendentemente gastronomica della Commedia.
1. Il Pane come simbolo del distacco
«Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e ’l salir per l’altrui scale.» (Paradiso, XVII)
Qui il pane è simbolo della sofferenza, del distacco, ma anche della quotidianità: in Toscana, il pane è sciocco, senza sale. Quello “altrui”, salato, diventa amaro perché legato all’esilio. Ma il riferimento al pane è anche un elemento che richiama l’identità culturale e territoriale: il sapore, la forma e la preparazione del pane erano distintivi dei luoghi, e Dante ne fa un segno della perdita di appartenenza.
In quel morso salato c’è tutto il dolore di un poeta esule, costretto a mendicare ospitalità lontano dalla sua amata Firenze.
2. La Fame: da Ugolino ai golosi
Nel Canto XXXIII dell’Inferno, Dante narra la storia del conte Ugolino della Gherardesca:
«Poscia, più che 'l dolor, poté 'l digiuno.»
La frase suggerisce l’orrenda possibilità che Ugolino abbia mangiato i corpi dei figli, ma è anche una potente immagine della fame come punizione estrema. Il digiuno, inteso come privazione e tormento, è qui non solo fisico ma anche morale.
Ugolino diventa una figura emblematica di una fame che consuma l’umanità e abbatte ogni limite etico. La potenza di questo episodio risiede nella sua ambiguità e nella crudezza, capaci di suscitare orrore e pietà al tempo stesso.
3. I Golosi: cibo come punizione
Nel Canto VI dell’Inferno, i golosi sono immersi in una pioggia fangosa:
«la pioggia etterna, maledetta, fredda e greve..."
Sorvegliati da Cerbero, soffrono una condizione opposta al piacere che cercavano: il cibo non nutre, ma degrada.
Dante punisce la gola con il ribrezzo, trasformando la passione per il cibo in tormento eterno. Il contrasto tra il desiderio di piacere e l’orrore della punizione accentua la condanna morale del peccato. Il mostro Cerbero, che li sbrana con rabbia, è l’incarnazione della fame insaziabile. In questa pioggia, il cibo si dissolve in fango, e con esso il significato positivo del nutrimento.
4. I Vini e i piaceri moderati
Nel Purgatorio, il cibo è vissuto con pentimento.
Nel canto XXIV, Forese Donati ammette i suoi eccessi, raccontando con tono ironico e affettuoso la propria passata voracità. Ma in Paradiso il nutrimento si fa simbolico: luce, conoscenza, estasi. L’alimentazione terrena viene trasfigurata: non più bisogni del corpo, ma desideri dell’anima.
Il vino, spesso simbolo di convivialità e trasgressione, lascia spazio alla sapienza, alla contemplazione. Tuttavia, anche qui, si può leggere un’eco di quel piacere moderato e giusto, quasi come una memoria dell’equilibrio che deve accompagnare l’essere umano nel cammino verso la salvezza.
A Tavola con Dante: un menu ispirato alla Divina Commedia
Il seguente menu si ispira simbolicamente e culturalmente ai tre regni della Commedia.
Ogni piatto non è solo una scelta gastronomica, ma una riflessione sul significato allegorico e antropologico del cibo in relazione al viaggio dantesco.
Uno studio che parte da alcuni chef che ci hanno suggerito piatti, insieme a storici e appassionati della Divina commedia….un percorso che sfocierà in un evento grandioso, che è la settimana Dantesca a Tavolo unico a Busto Arsizio, dal 7 al 14 aprile.
Intanto ecco qui un menu con alcuni dei piatti suggeriti ed elaborati.
Antipasto: Inferno
- Fegatini alla Fiorentina – Piatto tradizionale toscano, dal sapore deciso, legato alla cultura contadina e popolare. I fegatini, interiora cariche di simbolismo, rappresentano l’introspezione dolorosa e i tormenti dell’anima. Richiamano i corpi straziati dell’Inferno, e la loro consistenza cremosa ma forte trasmette fisicamente la sensazione di un gusto “infernale”.
- Zuppa di Pane Nero – Un omaggio al pane dell’esilio, rievocato da Dante come “salato” e amaro. Il colore scuro del pane, unito alla rusticità della zuppa, richiama le ambientazioni tetre e umide dei gironi infernali. Questo piatto simboleggia la povertà, la sofferenza e la fame, condizioni umane amplificate dalla dannazione eterna.
- Vino: Chianti Classico giovane – Tannico, vivace, rosso come il fuoco e il sangue, perfetto per accompagnare i sapori forti dell’Inferno e restituire l’atmosfera cupa ma passionale della prima cantica.
Primo: Purgatorio
- Pici con briciole e acciughe – La semplicità dei pici, pasta povera ma autentica, incontra le briciole (simbolo del pane quotidiano) e le acciughe (presenza salmastra e intensa, quasi penitenziale). Questo piatto rappresenta il cammino della purificazione: una cucina umile, che esalta ingredienti essenziali, come il Purgatorio esalta la speranza e il rinnovamento attraverso la fatica.
- Vino: Vernaccia di San Gimignano – Elegante e limpido, ma con una struttura profonda, come le anime del Purgatorio. Già apprezzata nel Medioevo, rappresenta l’elevazione progressiva del gusto e dello spirito.
Secondo: Paradiso
- Agnello in crosta di erbe con miele e frutta secca – L’agnello, per eccellenza simbolo della purezza e del sacrificio, si veste di erbe aromatiche che richiamano la freschezza dei campi celesti. Il miele e la frutta secca aggiungono una nota dolce e contemplativa. È un piatto che celebra la luce e l’armonia del Paradiso, con accenti di spiritualità.
- Vino: Vin Santo Riserva – Dolce, ma complesso, rappresenta la sublimazione del vino, ora non più segno di ebbrezza ma di comunione e trascendenza. Perfetto con la dolcezza meditativa del piatto.
Dolce: Pan di Dante.
- Pane dolce con fichi secchi, noci e mosto cotto – I fichi e le noci erano alimenti comuni nel Medioevo, usati nei dolci rustici. Il mosto cotto aggiunge profondità e intensità. Questo dolce è una sintesi della vita terrena e spirituale, in cui i sapori della terra si trasformano in memoria poetica. Un dessert che chiude il pasto con dolcezza e riflessione.
- Vino: Aleatico passito – Intenso, aromatico, perfetto per accompagnare il dolce e suggellare il viaggio con una nota persistente e profonda.
Questo percorso gastronomico non si limita a evocare suggestioni simboliche, ma costituisce una proposta coerente e filologica, in grado di offrire un’esperienza immersiva e didattica.
Ogni portata è pensata come un tassello di un racconto: si parte dalle profondità oscure dell’Inferno, dove i sapori forti e terreni dominano, si attraversa la sobrietà penitenziale del Purgatorio, con piatti semplici ma intensi, e si arriva infine alla leggerezza luminosa del Paradiso, dove ingredienti armonici e spirituali si fondono in una visione ideale della tavola. Il dolce, con la sua carica mnemonica e affettiva, rappresenta il sigillo finale di un banchetto che è anche viaggio interiore. In questo modo, la cena diventa un atto culturale e riflessivo, una forma di lettura multisensoriale dell’opera dantesca.
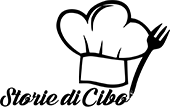






Seguici